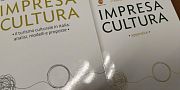|
Luca Scala
12 aprile 2004
Lingua algherese, da Cagliari solo indifferenza
Occorre ricordare che prima dell’approvazione della legge sarda del 1997 sulla tutela della lingua e della cultura della Sardegna, ci fu una dimenticanza sull’algherese, cui dovette mettere rimedio lo scomparso consigliere Lorettu

Vorrei fare qualche breve considerazione sull’articolo di Enrico Chessa «Anomalie catalane e sardità algherese» pubblicato in rete su questo sito. In generale, l’autore fa delle affermazioni assolutamente condivisibili e sacrosante: la valorizzazione dell’identità, la crescita dell’autostima, il prendere il futuro nelle proprie mani, senza stare ad aspettare stimoli esterni, l’unione da ricercare col territorio in cui viviamo (mi scuso per l’arbitrarietà della mia sintesi). Ciò è indiscutibile, non potrebbe esistere salvaguardia dell’identità senza questi presupposti. Il rovello dell’autore, però, sembra essere che, essendo Alghero –indiscutibilmente– una minoranza di origine catalana all’interno della minoranza sarda, il pericolo maggiore che corre la sua identità linguistico-culturale è, o può essere, una sorta di colonialismo imposto, distrattamente o volontariamente, dalla metropoli catalana: Barcellona. Propone, dunque, l’autore, di legare la tutela della nostra
minoranza “al quadrato” (mi si passi l’espressione) alla politica culturale sarda.
Questa, chiaramente, nel migliore dei mondi possibili, sarebbe la soluzione ideale. Purtroppo, le ultime notizie ci dànno abbastanza distanti dalla perfezione teorica...
La politica culturale sarda, in caso esista con una strutturazione sufficientemente progettata ed organizzata, non sembra avere grande interesse verso la “strana” Alghero. Colpa anche degli algheresi è ovvio. Occorre forse ricordare come, prima dell’approvazione della legge sarda
del 1997 sulla tutela della lingua e della cultura della Sardegna, ci fu una dimenticanza sull’algherese, al momento della redazione della proposta, cui dovette mettere rimedio in fretta e furia (in zona Cesarini) lo scomparso consigliere Lorettu (che era di Villanova come moltissimi altri algheresi!)? Eppure negli anni ’80-’90 la peculiarita linguistico-culturale di Alghero non era sconosciuta, giacché da almeno tre decenni radio, TV, giornali e riviste usavano ed abusavano
dell’aggettivo “catalano” quando si trattava di parlare di Alghero: dalla cultura all’instabilità politica, dalla gastronomia all’aeroporto, dal turismo allo sport o alla speculazione edilizia...
Ebbene, con tutto ciò, quando si è trattato di redigere la legge che doveva tutelare la lingua e la cultura sarde, e le altre minoranze che si trovano nella nostra isola, l’algherese fu distrattamente
dimenticato. Non si dice che fu ignorato per animo di punizione o altro, semplicemente non ci si ricordò di esso per banale sbadataggine. Non voglio tediare i lettori con il racconto di come, per esempio, recentemente siano stati respinti dalla Regione progetti di attività didattico-editoriali sulla lingua, nemmeno costosi, presentati da associazioni algheresi, e con motivazioni disarmanti tipo «non interessa» (voglio precisare che non sono stato coinvolto in nessuna di queste iniziative).
Anche qui, è probabile che più che altro influisca il fatto di stare a 300 Km dalla capitale sarda, con meno possibilità di seguire le pratiche nei palazzi della Regione. Ma forse là esiste un’oggettiva
incapacità di capire ciò che viene proposto da qua, perché riguarda una lingua allogena, ed è naturale che i funzionari preposti abbiano delle difficoltà; perciò, per non sapere né leggere né scrivere, come si suol dire, è molto facile che, sic et simpliciter, cassino le proposte sulla
lingua che da qui arrivano a Cagliari.
Allora gli algheresi dovremmo (e dovremo, effettivamente) stare sempre a rompere l’anima ai funzionari regionali per fare presente la nostra esistenza e le nostre necessità affatto peculiari, linguisticamente non omologabili con le varianti della lingua sarda? Indubbiamente esiste tutto un lavoro di sensibilizzazione da fare con gli enti provinciali (qua la cosa è già più facile, vista la poca
distanza da Sassari e la presenza di diversi algheresi nel Consiglio Provinciale) e regionali per fare in modo che l’algherese sia messo a fianco del sardo e non a piè di pagina, nelle determinazioni
riguardanti la cultura e la lingua, perché altrimenti la situazione offrirà pochi sbocchi.
Detto questo, la porta catalana la dovremo chiudere per il pericolo di influenze colonizzatrici, anche involontarie (milioni di abitanti contro i poco più di 40.000 algheresi, una sproporzione che potrebbe ottundere il senso della misura e dell’opportunità, là a ponente)? Questa sorta di paura, che non ho ben capito se è propria anche di Enrico Chessa, sembra diffusa in diversi personaggi “pubblici” algheresi.
Non si contesta mai, ad esempio, l’influenza dell’inglese nella vita quotidiana, quando all’ospedale domandano di pagare il “ticket” o si parla del taglio di fondi al “welfare”; però guai a parlare di contatti con gente della Catalogna (Valenza e le Baleari non sembrano contare, anzi, vengono viste con maggior benevolenza). Si arriva a livelli di stranezze poco comprensibili, in quest’ansia
demonizzatrice, come, per esempio, si può leggere quindicinalmente ne La Nuova Vetrina, dove la signora Antonella Salvietti –che è presente con una breve biografia nella Gran Enciclopèdia Catalana (!)– poetessa in algherese e membro storico del Centre d’Estudis Algueresos, arriva
ad affermare che l’algherese è stato influenzato molto più dallo spagnolo che dal catalano, visti i cambi politici all’interno della Corona Spagnola a partire dalla fine del ’400. Se si volesse essere
conseguenti, allora, un algherese, parlando la propria lingua, dovrebbe intendersi molto meglio con un abitante di Saragozza o di Granada, per esempio, che non con uno di Barcellona o di Girona. Basta provare e si vede quanto infondato sia il ragionamento. Altra pretesa un po’ stravagante è quella di imporre di scrivere l’algherese con la grafia italiana, che sarebbe come dire che anche
l’inglese, visto che è difficile da leggere nella sua grafia originale, dovrebbe scriversi utilizzando il codice ortografico dell’italiano. Però, se per l’inglese, che è una lingua diversa dall’italiano, si
rispetta, studiandolo, la sua grafia, per l’algherese, che è una variante della lingua catalana, perché non si dovrebbe fare lo stesso? Forse che l’algherese è una lingua bambina, non emancipata, cui non si debbono assegnare tutti i compiti e le funzioni di una lingua adulta? Una lingua minus habens, limitata, un patois buono solo per fare stornelli, qualche poesia patetica e maledire e bestemmiare?
Eppure l’esperienza dell’ultimo decennio dimostra che, se mai ce ne fosse bisogno, non è così.
La lingua è entrata nelle scuole e quasi duemila bambini la praticano ogni settimana, parlata e scritta (e non con la grafia italiana). Prima ancora, le associazioni algheresi l’hanno usata, e la usano, per manifestazioni pubbliche, per libri e riviste, per il teatro, a volte anche per i dibattiti politici. Ma niente, la Catalogna è il pericolo maggiore, di cui diffidare sommamente, perché, se non stiamo attenti, ci schiacciano come mosche.
Quanta poca considerazione si ha degli algheresi, barchette fatte di cerini nel mare in tempesta! Davvero siamo così sprovveduti e timorosi, immeritevoli di un minimo di fiducia? Davvero dobbiamo essere così provinciali da rinchiuderci la porta del mare e spalancare esclusivamente quella di terra? Forse si tratta solo di troppa insicurezza...
Questo rispetto ai catalani. Rispetto al resto della Sardegna, quando si dovrebbe smettere di
chiedere scusa per essere, da 650 quest’anno, di lontana origine forestiera, rispetto al resto della Sardegna (be’, come i galluresi, i sassaresi, i tabarchini, i veneti, i giuliano-dalmati...), per scontare
interamente il peccato originale dell’invasione medievale (previa bolla papale che assegnava la Sardegna e la Corsica al re d’Aragona, che era catalano)?
Condanna perpetua, come fa per esempio lo storico Antonio Budruni, dell’origine coloniale del ’300, ma poi scarsa attenzione sul mercanteggiamento Settecentesco (io mi prendo la Sicilia e tu la
Sardegna), molto più recente. Qual è il criterio di valutazione? Il presbitismo? Prego, spiegare i postulati, non si capisce bene che percorso poi si debba seguire per una loro corretta applicazione alla storia ed all’attualità, si rischia di sbagliarsi e di fare brutte figure a seguire il ragionamento...
Forse, a parte le ironie, si può avere un confronto diretto e franco (non inficiato da complessi di inferiorità e/o di persecuzione) con chi parla, con alcune differenze, la stessa lingua ed ha trovato maniere e strumenti per difenderla e valorizzarla a casa propria. Col resto della Sardegna Alghero non ha mai avuto problemi di rapporti, socialmente. Esiste un flusso migratorio che continua ancora oggi e sono state le genti del resto della Sardegna a portare avanti la lingua e la cultura peculiare di Alghero, a sentirla e farla integralmente propria, a esserne orgogliosi. Per quanto riguarda la lingua, però, dalle politiche di tutela del sardo non ci possono, purtroppo, arrivare indicazioni sfruttabili, perché è messo peggio dell’algherese, vista la disunione delle sue varianti e la realizzazione di iniziative poco più che testimoniali, che non incidono molto sulla società (ah, il protagonismo soffocante del folklore e del folklorismo!). Invece, dalla società dei diversi paesi di lingua catalana, nella penisola iberica e nelle isole, possono arrivare materiali, esperienze, consigli, mezzi e
strumenti che, adattati alla nostra realtà possono davvero essere efficaci, soprattutto nel campo dell’insegnamento e dell’uso pubblico ed amministrativvo della lingua.
Rifletterci senza troppi preconcetti, eccessi di animosità o di frustrazioni non farebbe male a nessuno.Due parole per finire.
L’autore della notizia di VilaWeb citata nell’articolo di Chessa è di Barcellona ma vive ad Alghero, naturale che scriva cumulativamente «la nostra cultura», parlando di Alghero e della Catalogna, non con intenzioni di annessione o di colonizzazione. Circa la canzoncina catalana tanto popolare a scuola, si potrebbe obiettare che forse i ragazzi sono più presi dall’ultima di Britney Spears, di Eminem, dei N.E.R.D. o di Kylie Minogue, più che dall’innocua «Joan petit», che è un semplice ma efficace strumento didattico per insegnare i nomi delle diverse parti del corpo, con una musica ed un ritmo decisamente allegri. Be’, forse Enrico Chessa non sa o non ricorda che fu introdotta e resa abbastanza popolare alla fine degli anni Settanta ad Alghero da Radio Sigma della buon’anima di
Antonio Soggiu, che la programmava sovente. Ricordo la nostra vicina di casa che all’epoca aveva una settantina di anni, che se la cantava e se la ritmava con molto piacere! Tutto ciò prima che si pensasse di introdurre in modo organizzato ed estensivo l’insegnamento dell’algherese nelle scuole con metodi sospettati di “colonialismo”...
|