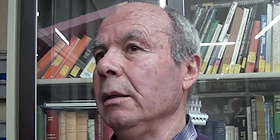|
Nicola Salvio
11 settembre 2014
L'opinione di Nicola Salvio
Per la scuola quale riforma e quale insegnante?
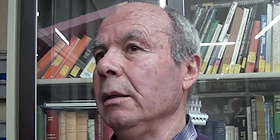 Ci risiamo. Ci prova anche il governo Renzi. Come i suoi predecessori. Quasi tutti. Non si conoscono, negli ultimi cinquant'anni, programmi politici, amministrativi o di governo che non abbiano individuato nella scuola un'assoluta priorità programmatica, coniugata, ovviamente, con l'ambizione di operarvi, nei relativi limiti delle proprie competenze territoriali e dei propri limiti istituzionali, interventi massicci e radicali, poi rivelatisi, alla prova dei fatti, il più delle volte, meri provvedimenti di restyling a cui solo la presunzione narcisistica e arrogante di qualche politico di giornata ha potuto attribuire l'etichetta nobile e nobilitante di Riforma. E però oggi più di ieri si attende con grande speranza una riforma vera del sistema scolastico, poiché nella fase attuale di crisi diffusiva del sistema Italia, aumenta, finalmente, la consapevolezza che è proprio la scuola, nelle cui aule si va costruendo, nei nostri giovani, il futuro del Paese, che può e deve diventare quel "meccanismo permanente di innovazione, sviluppo e qualità della democrazia" di cui si parla nel documento di presentazione della "buona scuola" da parte dell'attuale governo.
Ci risiamo. Ci prova anche il governo Renzi. Come i suoi predecessori. Quasi tutti. Non si conoscono, negli ultimi cinquant'anni, programmi politici, amministrativi o di governo che non abbiano individuato nella scuola un'assoluta priorità programmatica, coniugata, ovviamente, con l'ambizione di operarvi, nei relativi limiti delle proprie competenze territoriali e dei propri limiti istituzionali, interventi massicci e radicali, poi rivelatisi, alla prova dei fatti, il più delle volte, meri provvedimenti di restyling a cui solo la presunzione narcisistica e arrogante di qualche politico di giornata ha potuto attribuire l'etichetta nobile e nobilitante di Riforma. E però oggi più di ieri si attende con grande speranza una riforma vera del sistema scolastico, poiché nella fase attuale di crisi diffusiva del sistema Italia, aumenta, finalmente, la consapevolezza che è proprio la scuola, nelle cui aule si va costruendo, nei nostri giovani, il futuro del Paese, che può e deve diventare quel "meccanismo permanente di innovazione, sviluppo e qualità della democrazia" di cui si parla nel documento di presentazione della "buona scuola" da parte dell'attuale governo.
E dunque ci prova Renzi, e personalmente mi auguro sinceramente che ci riesca, anche se sono convinto che aspettare che sia una riforma o un progetto legislativo a cambiare il volto della scuola italiana e le diano una credibilità oggi in gran parte perduta presso l'opinione pubblica e forse ancor più fra i suoi stessi utenti, sia operazione doppiamente rischiosa. Innanzitutto un rischio di sistema, nella seria possibilità che venga snaturato il concetto stesso di scuola, confinandone riduttivamente il significato nella mera trasmissione di modelli culturali e ideologie (spesso abilmente camuffate sotto l'abito da sera dei «valori») che nell'attuale fase di elaborazione fanno segnare una gravissima caduta d'identità con conseguente crisi di rigetto da parte delle nuove generazioni. Mentre, invece, la scuola è, e dev'essere, essa, per definizione, creatrice di cultura e di processi.
E poi c'è un rischio individuale dell'insegnante e più generalmente dell'operatore scolastico: quello di abiurare alla responsabilità del cambiamento che è specificamente sua, quando volesse ancora essere soggetto del proprio lavoro e autenticamente padrone delle proprie scelte, e pertanto non delegabile a nessuno, tanto meno al potere politico, per esprimere fino in fondo le proprie capacità inventive (nel senso di intervento creativo pur all'interno del sistema).
Per essere più chiari: se politica scolastica e realtà scolastica sono due momenti intimamente uniti sul piano dell'impostazione operativa del problema, essi sono però irriducibilmente opposti su quello della proposizione filosofica, l'una essendo la tesi e l'altra l'antitesi; l'una la stasi e la codifica razionale e l'altra il fluido e il non ancora aggregato di quel complesso intreccio di rapporti e interferenze che si stabiliscono fra chi apprende, chi insegna e l'oggetto stesso dell'insegnamento. Questo non vuoi dire, naturalmente, che la relazione di reciprocità fra discente-docente-sapere debba o possa sfuggire dal fare i conti col sistema politico dal quale le derivano del resto legittimità e specularità; né che essa diventi, addirittura per altro verso, terra di nessuno o al limite campo di Marte per qualsiasi avventura didattica o licenza pedagogica. Si pensa piuttosto alla libertà-possibilità creativa di un insegnante serio, professionalmente preparato e scientificamente corretto che la scuola italiana non può più permettersi di fornire solo parzialmente e in casi e situazioni fortunate, perché ne va della credibilità dell'intero sistema.
E ridarle credibilità è forse oggi lo snodo centrale su cui si misura, a mio parere, la capacità di un intervento politico di riformare autenticamente la scuola: una mancanza di credibilità, coniugata con sempre maggiore sfiducia in un cambiamento reale della situazione, che, come già si accennava più sopra, investe oltre che l'esterno, l'interno stesso del mondo scolastico, a partire dagli studenti. Il fatto è che ancora ad oggi, quando si è forse finalmente alle soglie di un'auspicata riforma dell'intero sistema scolastico, si sente forte la mancanza di un solido baricentro didattico-pedagogico di riferimento per il mondo della scuola, che è, per sua natura e vocazione, certamente il più esposto alle istanze innovative provenienti da grandi processi di trasformazione sociale quali sono indubbiamente quelli in atto in Italia. E così avviene oggi ciò che avvenne a partire dal 1962 con l'istituzione della Scuola media unica, allorquando l'ingresso dì nuova e sempre più diversificata utenza nelle aule scolastiche, con conseguente maggiore e rinnovata domanda di trasmissione culturale pose la scuola di fronte a problemi di non facile soluzione.
Perché se è vero che per queste vie andò rapidamente spezzandosi il circolo chiuso di un sistema selettivo e destinato a fruitori che appartenevano alle stesse classi (medio-alte) che gestivano in prima persona un monopolio educativo imperniato sullo specifico disciplinare e sulla sistemazione di un bagaglio culturale consolidato ed ampiamente collaudato, è pure vero che le forze fresche portate a scuola dall'estensione della fascia dell'obbligo chiamarono i suoi operatori a misurarsi più da vicino con l'esterno, senza che fossero stati predisposti, parallelamente, gli strumenti necessari per farlo. E così, ad esempio, nel mentre entrava in crisi una classe insegnante abituata a mediare modelli ritagliati da un sistema di valori che era lo stesso degli utenti, non venne parallelamente emergendo con chiarezza il profilo di un insegnante nuovo, dalla professionalità ben definita in rapporto al ruolo ed alle crescenti competenze che le accelerate trasformazioni sociali e tecnologiche rapidissime postulavano con urgenza.
La causa profonda di una simile contraddizione risiedeva e risiede, del resto, nel sistema educativo stesso, e più propriamente nella "cultura" dell'educazione, così come essa si esprime in Italia. Una cultura che, soprattutto nella secondaria, defrauda l'alunno della sua identità adolescenziale, che si concretizza in forme precise di comportamenti, di attese e di bisogni, e, scaricandogli addosso programmi di studio modellati sulle misure di uno standard culturale definito nei laboratori ideologici delle centrali del potere economico, lo consegna sconosciuto ed indifeso ad insegnanti che il più delle volte nessuno mai ha preparato ad insegnare (o forse che si crede ancora, se mai vi si è creduto sul serio, ad una specie di vocazionismo didattico-pedagogico?)
Mutatis mutandis nella scuola di oggi si riscontrano problemi analoghi. Basterebbero due sole considerazioni per capire. In primis il presentismo imperante nella moderna società e soprattutto tra i giovani per cui il passato prossimo sconfina e scompare definitivamente nel passato remoto in un mescolamento confuso e pericoloso di cronaca e storia.
E poi l'abissale distanza tra il linguaggio e i linguaggi usati dalla scuola e nella scuola, e quelli normalmente utilizzati dai nostri studenti, mediati dal gruppo, dai social e dal web in generale: il mondo degli sms e dei 140 caratteri; la lingua senza espansione codificata ad esperanto mondiale. A creare linguaggi nuovi oggi non è più la scuola.
Probabilmente, allora, il problema più grosso che la moderna scienza pedagogica è chiamata a risolvere è proprio quello di un destinatario-alunno-studente che vive la propria esperienza culturale in maniera molto eccentrica rispetto ad altri, più immediati ed eccitanti centri di aggregazione. Né dietro tale eccentricità che si rivela drammaticamente nella mancanza di applicazione, di fiducia e di disponibilità al sapere scolastico, può ragionevolmente ipotizzarsi poca serietà, disimpegno e disattenzione dei giovani d'oggi. Essi vivono, in questo modo, probabilmente, la loro indifferenza ideologica verso una società non più in grado di elaborare modelli umani e culturali sostitutivi di miti ormai tramontati o irrimediabilmente datati.
Nella scuola i giovani identificano la società ed il sistema: l'indifferenza nei confronti della scuola è ansia di libertà. Passando per Freud, un tale atteggiamento potrebbe inscriversi in un processo di rimozione del padre (identificato nella scuola) come riflesso particolare del più generale conflitto generazionale. Questa considerazione autorizza a ben sperare, in quanto, essendo il rapporto col padre antinomico, la rimozione è soltanto il controaltare del bisogno che se ne ha. I giovani «sentono» il bisogno della scuola, ma per viverla come bisogno devono eliminare la scuola-padre-imposizione. Quando non vi riescono è l'indifferenza, la noia o addirittura la fuga da tutto ciò che è scuola. Bisognerebbe realizzare, allora, una scuola «differente» o almeno prevedere in essa sollecitazioni e stimoli tendenti a smuovere l'indifferenza dei destinatari, promuovendo delle forme di attività liberatorie e gratificanti. E' chiaro, a questo punto, come qualsiasi ipotesi o progetto di riforma o di rinnovamento non possa prescindere da uno scandaglio approfondito e da una accorta razionalizzazione delle realtà ambientali ed esistenziali in cui i discenti/destinatari esplicano la propria vita di relazione.
E porsi, infine, un interrogativo metodologico e domandarsi se ancora si vuole (meglio: se ancora convenga e a chi) una scuola che continui a ripetere il tracciato di un modello nazionale costruito nei laboratori ideologici delle centrali del potere economico; o si vuole invece una scuola che sperimenti l'avventura esaltante della semantizzazione dei rapporti interpersonali; di quelli contratti entro la famiglia, il gruppo, l'universo-lavoro, insomma dentro il proprio habitat culturale. Una scuola a cui siano manifesti, finalmente sveltati nella loro dimensione umana, i propri utenti. E' allora l'unica strada che l'insegnante ha a disposizione per recuperare i suoi utenti-alunni-studenti è quella di sottrarsi al ricatto della «spiegazione » e «divulgazione» di contenuti codificati, di un « messaggio» da confezionare ed elargire a qualsiasi costo. Che è, poi, anche l'unica via per riappropriarsi della propria più specifica, produttiva e stimolante funzione di programmatore di attività culturali e organizzatore delle modalità idonee all'apprendimento/appropriazione da parte del destinatario-alunno-studente dei mezzi di produzione e dei codici di trasmissione dei messaggi stessi.
Un itinerario metodologico che attraverso una accresciuta coscienza dei meccanismi di funzionamento dei registri e dei canali di una comunicazione qualsivoglia, preveda alla fine del percorso un destinatario/discente esso stesso facitore di messaggi; non solo fruitore ma produttore di cultura, e ciò non nella direzione di un meccanico (ed autoritario) ricambio ai vertici del potere culturale, quanto piuttosto al fine di dar voce ad espressioni e proposte comportamentali "altre", a ritagli di esperienza "diversi e alternativi" rispetto ai modelli del sistema. Questo, naturalmente, quando ci si convinca una volta per tutte che al bivio tra il "vivere" e l'«esser vissuti», tra il «parlare» e l'«essere parlati» c'è il discorso di una corretta comunicazione intersoggettiva, legata alle possibilità di afferrare e gestire il funzionamento dei circuiti comunicativi. È possibile tutto questo attraverso un intervento legislativo di riforma della scuola?
Forse sì, a patto di favorire una rigenerazione "dall'interno" del sistema, coniugata a mirati atti di politica culturale "visionaria" e a coraggiosi interventi di natura economico-finanziaria che possano consentire di: dotare gli insegnanti di un sistema strutturato e permanente di accompagnamento alla pratica didattica e di formazione in servizio; promuovere gli insegnanti da solitari interpreti di singoli spartiti a "comunità educante", sotto il segno di percorsi metodologici, strategie didattiche ed obiettivi pedagogici coerenti e confluenti; liberarli dall'invasione, e dall'invadenza, di mille soggetti istituzionali e paraistituzionali che si accalcano e si sovrappongono, frastagliati e disorganici nei loro interventi sugli studenti, quasi fossero prede da conquistare. Dotarli di strumenti, risorse e spazi fisici e temporali per rispondere ad una platea di studenti sempre più complessa, problematica ed estremamente differenziata, ma anche sottrarli alla troppo usuale tendenza a barricarsi dietro le porte chiuse della propria aula, custodi autoreferenziali gelosi delle proprie liturgie e delle proprie ricette didattiche fatte in casa e promuoverli ad intelligenti e preparati programmatori di attività cognitive e di ricerca, nonché a segmenti attivi di un progetto didattico multilineare in cui siano coinvolti (ognuno al proprio livello) tutti gli altri operatori dell'intera struttura scolastica (studenti compresi, ovviamente); offrirgli la possibilità di costituire e lavorare in rete, così per mettere in circolo le sue buone pratiche e confrontarle con altri colleghi; valorizzare, non solo ma anche economicamente in maniera significativa, il loro lavoro con un sistema integrato di valutazione che tenga conto sia della quantità che della qualità, del diverso grado di responsabilità delle prestazioni e dei processi didattico-pedagogici attivati, affidato ad un soggetto plurale in grado di apprezzare anche i tempi lunghi che per sua natura abbisogna un insegnamento per rendere manifesti i suoi frutti; arricchire gli insegnanti di tutti i moderni mezzi di comunicazione telematica per rafforzare, non per semplificare e ridurre la comunicazione stessa, perché la scuola deve innanzitutto rimanere (o essere, o diventare) una struttura di cui si possa creare. Gli esperimenti di computerizzazione dell'apprendimento condotti ad esempio qualche anno fa nell'Harvard University da questo punto di vista appaiono sconcertanti. All'uomo che si confronta con la macchina (sia pure «impostata» da un altro uomo) nel processo cognitivo, preferisco personalmente l'uomo che parla e discute con l'altro uomo la cui risposta non sia già programmata, ieri come oggi e oggi come domani, ma aperta all'emozione e, perché no, anche all'errore, se l'errore ti fa dare ancora il nome di uomo. E' la realizzazione di un insegnante-operatore scolastico-uomo l'obiettivo che una scuola nuova, riformata davvero, deve porsi innanzitutto.
* ex dirigente scolastico del Liceo classico, linguistico e artistico "Manno" ed attuale segretario politico del Partito dei Riformatori sardi di Alghero
|
|
|
|
|
 |
|
18:17
Durante l’Open Day di sabato 17 gennaio sarà possibile visitare i laboratori dell’indirizzo Tecnico in Biotecnologie Sanitarie e Ambientali – Biologia, Microbiologia, Chimica, Igiene, Anatomia e Fisica – dove verranno proposte dimostrazioni pratiche e presentate strumentazioni avanzate che riproducono contesti di lavoro reali
|
|
|
 |
|
15:46
Due incontri di orientamento, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, che si terranno sabato 17 e sabato 24 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19, nelle sedi di via Diez e di via degli Orti
|
|
|
 |
|
13/1/2026
Il viaggio, nato da una solida convenzione con l´ateneo cinese, ha permesso ai ragazzi di immergersi in una realtà urbana da 30 milioni di abitanti. Oltre alle lezioni nel campus, il programma ha offerto un tuffo nelle tradizioni: arti marziali, tiro con l´arco e intaglio della carta
|
|
|
 |
|
12/1/2026
È una giunta incapace di governare quella di Alessandra Todde. Incapace di approvare il piano dí dimensionamento della rete scolastica e per questo commissariata dal governo. Incapace di guidare i processi e difendere gli interessi della Sardegna.
|
|
|
 |
|
13/1/2026
I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con una grafica divertente, ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium logistics partner
|
|
|
 |
|
13/1/2026
La Regiona Sardegna tiene la linea e resiste. Vergogna il commissariamento del governo per i dimensionamenti scolastici. La Regione Sardegna Resiste e fa bene
|
|
|
 |
|
12/1/2026
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento delle Regioni Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria che non hanno ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico
|
|
|
 |
|
13/1/2026
Open day al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “E.Fermi” di Alghero, sabato 17 gennaio e sabato 31 gennaio, dalle 16 alle 19. L’Istituto sarà una grande “agorà” dove i nostri studenti si racconteranno attraverso mostre, eventi, rappresentazioni e attività di laboratorio
|
|
|
|
|
 14 gennaio 14 gennaio  14 gennaio 14 gennaio  13 gennaio 13 gennaio
|